- Home
- Jhumpa Lahiri
In Other Words Page 12
In Other Words Read online
Page 12
So che ci saranno tantissime cose da correggere, da riscrivere.
So che la mia vita, in quanto scrittrice, non sarà più la stessa.
Il racconto s’intitola Lo scambio.
Di cosa parla? La protagonista è una traduttrice insofferente che si trasferisce in una città imprecisata, alla ricerca di un cambiamento. Ci arriva da sola, con quasi nulla, tranne un golfino nero.
Non so come leggere il racconto, non so cosa pensarne. Non so se funziona. Mi mancano le capacità critiche per giudicarlo. Benché sia venuto da me, non sembra completamente mio. Sono certa solo di una cosa: non lo avrei mai scritto in inglese.
Odio analizzare ciò che scrivo. Ma qualche mese dopo, un mattino mentre corro in villa Doria Pamphilj, mi viene in mente, tutto a un tratto, il significato di questo strano racconto: il golfino è la lingua.
LO SCAMBIO
C’era una donna, una traduttrice, che voleva essere un’altra persona. Non c’era un motivo chiaro. Era sempre stato così.
Aveva degli amici, una famiglia, un appartamento, un lavoro. Aveva abbastanza soldi, godeva di buona salute. Aveva, insomma, una vita fortunata, di cui era grata. L’unica cosa che la affliggeva era quello che la distingueva dagli altri.
Quando pensava a ciò che possedeva, provava una mite repulsione, perché ogni oggetto, ogni cosa che le apparteneva, le dava prova della sua esistenza. Ogni volta che aveva un qualsiasi ricordo della sua vita passata, era convinta che un’altra versione sarebbe stata migliore.
Si considerava imperfetta, come la prima stesura di un libro. Voleva generare un’altra versione di se stessa, nello stesso modo in cui poteva trasformare un testo da una lingua a un’altra. A volte aveva l’impulso di rimuovere la sua presenza dalla terra, come se fosse un filo sull’orlo di un bel vestito, da tagliare via con un paio di forbici.
Eppure non voleva suicidarsi. Amava troppo il mondo, la gente. Amava fare lunghe passeggiate nel tardo pomeriggio osservando ciò che la circondava. Amava il verde del mare, la luce del crepuscolo, i sassi sparsi sulla sabbia. Amava il sapore di una pera rossa in autunno, la luna piena e pesante d’inverno che brillava fra le nuvole. Amava il calore del suo letto, un buon libro da leggere senza interruzione. Per godere di questo, sarebbe vissuta per sempre.
Volendo capire meglio il motivo per cui si sentiva così, decise un giorno di eliminare i segni della sua esistenza. Tranne una piccola valigia, buttò o diede via tutto. Voleva vivere in solitudine, come un monaco, proprio per affrontare ciò che non riusciva a sopportare. Ai suoi amici, alla famiglia, all’uomo che la amava, disse che doveva andarsene per un po’.
Scelse una città in cui non conosceva nessuno, non capiva la lingua, dove non faceva né troppo caldo né troppo freddo. Portò un guardaroba quanto più semplice possibile, tutto in nero: un abito, un paio di scarpe, e un golfino di lana leggera, morbida, con cinque piccoli bottoni.
Arrivò mentre la stagione stava cambiando. Faceva caldo al sole, freddo all’ombra. Prese in affitto una camera. Camminava per ore, vagava senza meta, senza parlare. La città era piccola, piacevole ma priva di personalità, senza turisti. Sentiva i rumori, osservava la gente: chi andava in fretta al lavoro, chi era seduto sulle panchine, come lei, con un libro o con un cellulare, a prendere il sole. Quando aveva fame, mangiava qualche cosa seduta su una panchina. Quando era stanca, andava al cinema a vedere un film.
I giorni si facevano brevi, scuri. Pian piano gli alberi si spogliavano dei colori, delle foglie. La mente della traduttrice si svuotava. Cominciava a sentirsi leggera, anonima. Immaginava di essere una foglia che cadeva, identica a ogni altra.
Di notte dormiva bene. Di mattina si svegliava senza ansie. Non pensava né al futuro, né alle tracce della sua vita. Sospesa nel tempo, come una persona senza ombra. Eppure era viva, si sentiva più viva che mai.
In una brutta giornata, piovosa, ventosa, si mise al riparo sotto il cornicione di un edificio in pietra. La pioggia scrosciava. Non aveva un ombrello, neanche un cappello. La pioggia colpiva il marciapiede, con un suono insistente, continuo. Pensava al viaggio che fa l’acqua, che da sempre cade dalle nuvole, penetrando nella terra, riempiendo i fiumi, arrivando, alla fine, al mare.
La strada era piena di pozzanghere, la facciata del palazzo di fronte a lei era coperta di annunci illeggibili. La traduttrice si accorse di varie donne che entravano e uscivano dal portone. Di tanto in tanto una di loro, da sola o in un piccolo gruppo, arrivava, premeva un campanello, poi entrava. Curiosa, decise di seguirle.
Oltre il portone si doveva attraversare un cortile in cui la pioggia era confinata, come se piovesse in una stanza senza soffitto. Si fermò un momento per guardare il cielo, anche se si bagnava. Più avanti c’era una scala, scura, un po’ sconnessa, dove alcune signore scendevano, altre salivano.
Sul pianerottolo c’era una donna alta, magra, con una faccia grinzosa ma ancora bella. Aveva i capelli corti, chiari, era vestita di nero. L’abito era trasparente, senza una forma precisa, con maniche lunghe e diafane, come due ali. Questa donna accoglieva le altre, con le braccia spalancate.
Venite, venite, ci sono tante cose da vedere.
Dentro l’appartamento la traduttrice lasciò la sua borsa nel corridoio, su un lungo tavolo, come facevano le altre. Oltre il corridoio c’era un grande salotto. C’era una fila piena di abiti neri, lungo un appendiabiti accanto alla parete.
Gli abiti erano come soldati, sull’attenti, ma inanimati. In un’altra parte del salotto c’erano divani, candele accese, un tavolo al centro pieno di frutta, formaggio, una densa torta al cioccolato. In un angolo, un alto specchio diviso in tre parti, in cui ci si poteva guardare da diverse prospettive.
La proprietaria dell’appartamento, che aveva disegnato questi vestiti neri, era seduta su un divano, fumava e chiacchierava. Parlava la lingua del posto perfettamente, ma con un leggero accento. Era una straniera, come la traduttrice.
Benvenute. Prego, mangiate, guardatevi intorno, accomodatevi.
Alcune donne si erano già spogliate, e stavano provando vestiti, sollecitando le opinioni delle altre. Erano una collezione di braccia, gambe, anche, vite. Variazioni incessanti. Sembrava che tutte loro si conoscessero.
La traduttrice si tolse il golfino, si spogliò. Cominciò a provare tutti i vestiti della sua taglia, uno dopo l’altro, metodicamente, come se fosse un compito. C’erano pantaloni, giacche, gonne, camicie, vestiti. Tutti neri, fatti di stoffe morbide, leggere.
Sono ideali per viaggiare, disse la proprietaria. Sono comodi, moderni, versatili. Si possono lavare a mano in acqua fredda. Non si sgualciscono.
Le altre donne erano d’accordo. Dicevano che ormai si mettevano soltanto i vestiti disegnati dalla proprietaria. Li si trovava soltanto andando a casa sua, soltanto grazie a un invito privato. Soltanto in questo modo, segreto, nascosto, festivo.
La traduttrice stava davanti allo specchio. Studiava la propria immagine. Ma era distratta, c’era la presenza di un’altra donna dietro lo specchio, in fondo al corridoio. Era diversa dalle altre. Stava lavorando a un tavolo, con un ferro da stiro, con un ago in bocca. Aveva occhi stanchi, una faccia addolorata.
I vestiti erano eleganti, ben fatti. Anche se le stavano benissimo, alla traduttrice non piacevano. Dopo aver provato l’ultima cosa, decise di uscire. Non si sentiva se stessa in quei vestiti. Non voleva acquistare o accumulare niente di più.
C’erano mucchi di abiti dappertutto, sul pavimento, sui divani, sulle poltrone, come tante pozzanghere scure. Dopo aver rovistato un po’, trovò il suo. Però mancava il golfino nero. Aveva cercato in tutti i mucchi ma non era riuscita a ritrovarlo.
Il salotto era quasi vuoto. Mentre la traduttrice cercava il suo golfino la maggior parte delle donne era andata via. La proprietaria stava preparando una ricevuta per la penultima. Rimaneva solo la traduttrice.
La proprietaria la guardava, come se fosse consapevole per la prima volta della sua presenza.
«E lei, cosa ha deciso di prendere?»
«Niente. Mi manca un golfino, il mio.»
«Il colore?»
«Nero.»
«Ah, mi dispiace.»
La proprietaria chiamò la donna dietro lo specchio. Le chiese di raccogliere i vestiti dal pavimento, di rimettere tutto a posto.
«A questa signora manca un golfino nero» disse. «Non la conosco» continuò. «Come mi ha trovata?»
«Ero fuori. Ho seguito le altre. Non sapevo cosa ci fosse dentro.»
«Non le piacciono, i vestiti?»
«Mi piacciono ma non mi servono.»
«Da dove viene?»
«Non sono di qui.»
«Neanch’io. Ha fame? Gradisce del vino? Della frutta?»
«No, grazie.»
«Scusate.»
Era la donna che lavorava per la proprietaria. Mostrò qualcosa, un indumento, alla traduttrice.
«Ecco» disse la proprietaria. «Era nascosto, abbiamo ritrovato il suo golfino.»
La traduttrice lo prese. Ma aveva capito subito, senza neanche metterselo, che non era il suo. Era un altro, sconosciuto. La lana era più ruvida, il nero meno intenso, ed era di una misura diversa. Quando lo indossò, quando si guardò nello specchio, lo sbaglio le apparve evidente.
«Questo non è il mio.»
«Cosa dice?»
«Il mio è simile, ma non è questo. Non riconosco questo golf. Non mi sta bene.»
«Ma dovrebbe essere il suo. La donna ha sistemato tutto. Non rimane niente sul pavimento, niente sui divani, guardi.»
La traduttrice non voleva accettare l’altro golfino. Ne provava antipatia, ribrezzo. «Questo non è il mio. Il mio è sparito.»
«Ma come?»
«Forse un’altra donna l’ha preso senza accorgersene. Forse c’è stato uno scambio. Forse c’erano delle altre clienti che indossavano un golfino come questo?»
«Non me lo ricordo. Va bene, posso controllare, aspetti.»
La proprietaria si sedette di nuovo sul divano. Accese una sigaretta. Poi, cominciò a fare una serie di chiamate. Spiegava a una donna dopo l’altra quello che era successo. Scambiava due parole con ognuna.
La traduttrice aspettava. Era convinta che qualcuna di loro avesse preso il suo golf, e che quello lasciato a lei appartenesse a un’altra.
La proprietaria posò il cellulare. «Mi dispiace, signora. Ho chiesto a tutte. Nessuna indossava un golfino nero oggi da me. Solo lei.»
«Ma questo non è il mio.»
Era sicura che non fosse il suo. Al tempo stesso sentiva un’incertezza tremenda che la consumava, che cancellava tutto, che la lasciava senza nulla.
«Grazie di essere venuta, arrivederla» disse la proprietaria. Non disse niente di più.
La traduttrice si sentiva sconcertata, vuota. Era venuta in questa città cercando un’altra versione di sé, una trasfigurazione. Ma aveva capito che la sua identità era insidiosa, una radice che lei non sarebbe mai riuscita a estirpare, un carcere in cui si sarebbe incastrata.
Nel corridoio voleva salutare la donna che lavorava per la padrona, dietro lo specchio, a un tavolo. Ma non c’era più.
Tornò a casa, sconfitta. Fu costretta a indossare l’altro golfino, perché pioveva ancora. Quella sera si addormentò senza mangiare, senza sognare.
Il giorno dopo, quando si svegliò, vide un golfino nero su una sedia nell’angolo della camera. Le era di nuovo familiare. Sapeva che era sempre stato il suo, e che la sua reazione il giorno precedente, la piccola scena che aveva fatto di fronte alle altre due donne, era stata completamente irrazionale, assurda.
Eppure questo golfino non sembrava più lo stesso, non quello che aveva cercato. Quando lo vide, non provava più nessun ribrezzo. Anzi, quando lo indossò, lo preferì. Non voleva ritrovare quello perso, non le mancava. Ora, quando lo indossava, era un’altra anche lei.
IL RIPARO FRAGILE
Quando leggo in italiano mi sento un’ospite, una viaggiatrice. Ciononostante, quello che faccio sembra un compito ragionevole, accettabile.
Quando scrivo in italiano mi sento un’intrusa, un’impostora. Sembra un compito contraffatto, innaturale. Mi accorgo di aver oltrepassato un confine, di sentirmi persa, di essere in fuga. Di essere completamente straniera.
Quando rinuncio all’inglese rinuncio alla mia autorevolezza. Sono traballante anziché sicura. Sono debole.
Da dove viene l’impulso di allontanarmi dalla mia lingua dominante, la lingua da cui dipendo, da cui provengo come scrittrice, per darmi all’italiano?
Prima di diventare un’autrice mi mancava un’identità chiara, nitida. È stato attraverso la scrittura che sono riuscita a sentirmi realizzata. Ma quando scrivo in italiano non mi sento così.
Cosa vuol dire scrivere senza la propria autorevolezza? Posso definirmi un’autrice, senza sentirmi autorevole?
Com’è possibile, quando scrivo in italiano, che mi senta sia più libera sia inchiodata, costretta?
Forse perché in italiano ho la libertà di essere imperfetta.
Come mai mi attrae questa nuova voce, imperfetta, scarna? Come mai mi soddisfa la penuria? Cosa vuol dire rinunciare a un palazzo per abitare quasi per strada, sotto un riparo così fragile?
Forse perché dal punto di vista creativo non c’è nulla di tanto pericoloso quanto la sicurezza.
Mi chiedo quale sia il rapporto tra libertà e limitazioni. Mi chiedo come una prigione possa somigliare al paradiso.
Mi viene in mente qualche riga di Verga che ho scoperto di recente: «Pensare che avrebbe potuto bastarmi quest’angolo di terra, uno spicchio di cielo, un vaso di fiori, per godere tutte le felicità del mondo, se non avessi provato la libertà e se non mi sentissi in cuore la febbre roditrice di tutte le gioie che son fuori di queste mura!»
Chi parla è la protagonista di Storia di una capinera, una novizia di clausura che si sente intrappolata nel convento, che vagheggia la campagna, la luce, l’aria.
Io, in questo momento, preferisco il recinto. Quando scrivo in italiano, mi basta quello spicchio di cielo.
Mi rendo conto che la voglia di scrivere in una nuova lingua deriva da una specie di disperazione. Mi sento tormentata, come la capinera di Verga. Come lei, desidero altro: qualcosa che probabilmente non dovrei desiderare. Ma penso che l’esigenza di scrivere derivi sempre dalla disperazione insieme alla speranza.
So che si dovrebbe conoscere a fondo la lingua in cui si scrive. So che mi manca una vera padronanza. So che la mia scrittura in italiano è qualcosa di prematuro, avventato, sempre approssimativo. Voglio chiedere scusa. Voglio spiegare la fonte di questo mio slancio.
Perché scrivo? Per indagare il mistero dell’esistenza. Per tollerare me stessa. Per avvicinare tutto ciò che si trova al di fuori di me.
Se voglio capire quello che mi colpisce, quello che mi confonde, quello che mi angoscia, in breve, tutto ciò che mi fa reagire, devo metterlo in parole. La scrittura è il mio unico modo per assorbire e per sistemare la vita. Altrimenti mi sgomenterebbe, mi sconvolgerebbe troppo.
Ciò che passa senza esser messo in parole, senza esser trasformato e, in un certo senso, purificato dal crogiuolo dello scrivere, non significa nulla per me. Solo le parole che durano mi sembrano reali. Hanno un potere, un valore superiore a noi.
Visto che io provo a decifrare tutto tramite la scrittura, forse scrivere in italiano è semplicemente il mio modo per apprendere la lingua nel modo più profondo, più stimolante.
Fin da ragazza appartengo soltanto alle mie parole. Non ho un Paese, una cultura precisa. Se non scrivessi, se non lavorassi alle parole, non mi sentirei presente sulla terra.
Cosa significa una parola? E una vita? Mi pare, alla fine, la stessa cosa. Come una parola può avere tante dimensioni, tante sfumature, una tale complessità, così una persona, una vita. La lingua è lo specchio, la metafora principale. Perché in fondo il significato di una parola, così come quello di una persona, è qualcosa di smisurato, di ineffabile.
L’IMPOSSIBILITÀ
In un numero di «Nuovi Argomenti», leggendo un’intervista con il romanziere Carlos Fuentes, trovo questo: «È estremamente utile sapere che non si potrà mai raggiungere certe vette».
Fuentes si riferisc
e a certi capolavori letterari – opere geniali come Don Chisciotte, per esempio – che restano intoccabili. Credo che queste vette abbiano un doppio ruolo, considerevole, per gli scrittori: ci fanno puntare alla perfezione e ci ricordano la nostra mediocrità.
Come scrittrice, in qualsiasi lingua, devo tenere conto della presenza di grandissimi autori. Devo accettare la natura del mio contributo rispetto al loro. Pur sapendo che non riuscirò mai a scrivere come Cervantes, come Dante, come Shakespeare, scrivo comunque. Devo gestire l’ansia che queste vette possono suscitare. Altrimenti, non oserei scrivere.
Ora che scrivo in italiano, l’osservazione di Fuentes mi sembra ancora più pertinente. Devo accettare l’impossibilità di raggiungere la vetta che mi ispira, ma allo stesso tempo mi porta via spazio. Ora la vetta non è l’opera di un altro scrittore più brillante di me, ma invece il cuore della lingua in sé. Pur sapendo che non riuscirò a trovarmi sicuramente dentro questo cuore, cerco, attraverso lo scrivere, di raggiungerlo.
Mi chiedo se sto andando controcorrente. Vivo in un’epoca in cui quasi tutto sembra possibile, in cui nessuno vuole accettare alcun limite. Possiamo inviare un messaggio in un istante, possiamo andare da un capo all’altro del mondo in una giornata. Possiamo vedere chiaramente una persona che non sta accanto a noi. Grazie alla tecnologia, niente attesa, niente distanza. Ecco perché si può dire tranquillamente che il mondo è più piccolo rispetto al passato. Siamo sempre connessi, raggiungibili. La tecnologia rifiuta la lontananza, oggi più che mai.
Eppure, questo mio progetto in italiano mi rende acutamente consapevole delle distanze immani tra le lingue. Una lingua straniera può significare una separazione totale. Può rappresentare, ancora oggi, la ferocia della nostra ignoranza. Per scrivere in una nuova lingua, per penetrarne il cuore, nessuna tecnologia aiuta. Non si può accelerare il processo, non si può abbreviarlo. L’andamento è lento, zoppicante, senza scorciatoie. Più capisco la lingua, più si ingarbuglia. Più mi avvicino, più si allontana. Ancora oggi il distacco tra me e l’italiano rimane insuperabile. Ho impiegato quasi la metà della mia vita per fare appena due passi. Per arrivare solo qui.

 The Namesake
The Namesake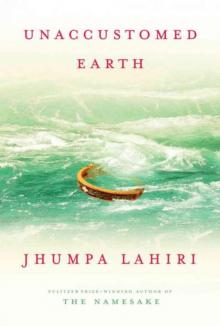 Nobody's Business
Nobody's Business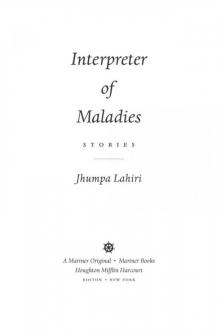 Interpreter of Maladies
Interpreter of Maladies Hell-Heaven
Hell-Heaven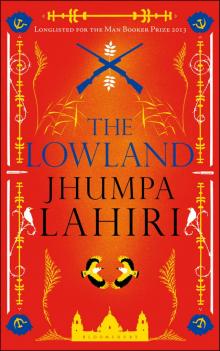 The Lowland
The Lowland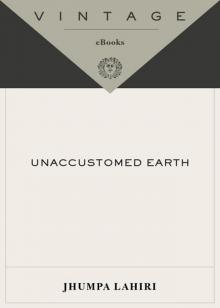 Unaccustomed Earth
Unaccustomed Earth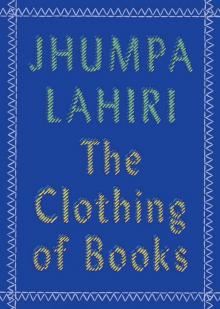 The Clothing of Books
The Clothing of Books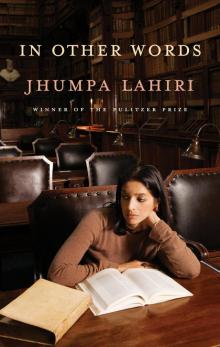 In Other Words
In Other Words The Penguin Book of Italian Short Stories
The Penguin Book of Italian Short Stories