- Home
- Jhumpa Lahiri
In Other Words Page 10
In Other Words Read online
Page 10
Qualche settimana dopo aver attraversato il piccolo lago nascosto, faccio una seconda traversata. Molto più lunga, ma niente di faticoso. Sarà la prima vera partenza della mia vita. Questa volta in nave, attraverso l’oceano Atlantico, per vivere in Italia.
IL DIZIONARIO
Il primo libro italiano che compro è un dizionario tascabile, con definizioni in inglese. Sto per andare a Firenze per la prima volta, nel 1994. Vado in una libreria a Boston, con un nome italiano: Rizzoli. Una bella libreria, raffinata, che non c’è più.
Non compro una guida turistica, anche se è la mia prima visita in Italia, anche se non conosco per niente Firenze. Grazie a un mio amico, ho già l’indirizzo di un albergo. Sono una studentessa, ho pochi soldi. Credo che un dizionario sia più importante.
Quello che scelgo ha una copertina di plastica, verde, indistruttibile, impermeabile. È leggero, più piccolo della mia mano. Ha più o meno le stesse dimensioni di una saponetta. Sul retro c’è scritto che contiene circa quarantamila parole italiane.
Quando, gironzolando per gli Uffizi, tra le gallerie quasi deserte, mia sorella si accorge di aver perso il suo cappello, apro il dizionario. Vado alla parte inglese, per apprendere come si dice cappello in italiano. In qualche modo, sicuramente sbagliato, dico a una guardia che abbiamo perso un cappello. Miracolosamente, capisce quello che dico, ed entro breve il cappello è ritrovato.
Da allora, per molti anni, ogni volta che vado in Italia, porto questo dizionario con me. Lo metto sempre in borsa. Cerco le parole quando sono per strada, quando torno in albergo dopo un giro, quando provo a leggere un articolo sul giornale. Mi guida, mi protegge, mi spiega tutto.
Diventa sia una mappa che una bussola, senza la quale so che sarei smarrita. Diventa una specie di genitore, autorevole, senza il quale non posso uscire. Lo ritengo un testo sacro, pieno di segreti, di rivelazioni.
Sulla prima pagina, a un certo punto, scrivo: «provare a = cercare di».
Questo frammento casuale, questa equazione lessicale, può essere una metafora dell’amore che provo per l’italiano. Una cosa che, alla fine, non è altro che un ostinato tentativo, una prova continua.
Quasi vent’anni dopo aver comprato il primo dizionario, decido di trasferirmi a Roma per una lunga permanenza. Prima di partire, chiedo a un mio amico, che ha vissuto lì per parecchi anni, se mi serve un dizionario elettronico in italiano, tipo un’app per il cellulare, per cercare una parola in qualsiasi momento.
Ride. Mi dice: «Tra poco abiterai dentro un dizionario italiano».
Ha ragione. Dopo un paio di mesi a Roma, pian piano mi rendo conto di non controllare il dizionario tanto spesso. Quando esco, tende a restare in borsa, chiuso. Di conseguenza comincio a lasciarlo a casa. Mi accorgo di una svolta. Di un senso di libertà, e al contempo di perdita. Di esser cresciuta, almeno un po’.
Oggi ho tanti altri dizionari sulla mia scrivania, più grandi, corposi. Ne ho due monolingue, senza alcun termine inglese. Ormai la copertina di quello piccolino appare un po’ sbiadita, un po’ sporca. Le pagine sono ingiallite. Alcune si stanno staccando dalla rilegatura.
Resta, di solito, sul comodino, così posso controllare facilmente una parola sconosciuta mentre leggo. Questo libro mi permette di leggerne altri, di aprire la porta di una nuova lingua. Mi accompagna, ancora adesso, quando vado in vacanza, durante i viaggi. È diventato una necessità. Se per caso, quando parto, dimentico di portarlo con me, mi sento un po’ a disagio, così come mi sentirei se dimenticassi lo spazzolino da denti o un paio di calze di ricambio.
Ormai quel dizionarietto sembra più un fratello che un genitore. Eppure mi serve, mi guida ancora. Rimane pieno di segreti. Rimane sempre, questo piccolo libro, più grande di me.
IL COLPO DI FULMINE
Nel 1994, quando con mia sorella decidiamo di regalarci un viaggio in Italia, scegliamo Firenze. Sto studiando, a Boston, l’architettura del Rinascimento: la Cappella Pazzi di Brunelleschi, la Biblioteca medicea-laurenziana di Michelangelo. Arriviamo a Firenze all’imbrunire, qualche giorno prima di Natale. Faccio la prima passeggiata al buio. Mi trovo in un luogo intimo, sobrio, gioioso. Negozi addobbati per la stagione. Stradine strette, stipate di gente. Alcune sembrano più corridoi che strade. Ci sono turisti come me e mia sorella, ma non tanti. Vedo le persone che vivono qui da sempre. Camminano in fretta, indifferenti ai palazzi. Attraversano le piazze senza fermarsi.
Io sono venuta per una settimana, per vedere i palazzi, per ammirare le piazze, le chiese. Ma dall’inizio il mio rapporto con l’Italia è tanto uditivo quanto visuale. Benché ci siano poche macchine, la città ronza. Mi rendo conto di un rumore che mi piace, delle conversazioni, delle frasi, delle parole che sento ovunque vada. Come se tutta la città fosse un teatro che ospita un pubblico leggermente inquieto, che chiacchiera, prima dell’inizio di uno spettacolo.
Sento l’eccitazione con cui i bambini si augurano buon Natale per la strada. Sento una mattina all’albergo la tenerezza con cui la donna che pulisce la camera mi chiede: Avete dormito bene? Quando un signore dietro di me vorrebbe passare sul marciapiede, sento la lieve impazienza con cui mi domanda: Permesso?
Non riesco a rispondere. Non sono capace di avere nessun dialogo. Ascolto. Quello che sento, nei negozi, nei ristoranti, desta una reazione istantanea, intensa, paradossale. L’italiano sembra già dentro di me e, al tempo stesso, del tutto esterno. Non sembra una lingua straniera, benché io sappia che lo è. Sembra, per quanto possa apparire strano, familiare. Riconosco qualche cosa, nonostante non capisca quasi nulla.
Cosa riconosco? È bella, certo, ma non c’entra la bellezza. Sembra una lingua con cui devo avere una relazione. Sembra una persona che incontro un giorno per caso, con cui sento subito un legame, un affetto. Come se la conoscessi da anni, anche se c’è ancora tutto da scoprire. So che sarei insoddisfatta, incompleta, se non la imparassi. Mi rendo conto che esiste uno spazio dentro di me per farla stare comoda.
Sento una connessione insieme a un distacco. Una vicinanza insieme a una lontananza. Quello che provo è qualcosa di fisico, di inspiegabile. Suscita una smania indiscreta, assurda. Una tensione squisita. Un colpo di fulmine.
Trascorro la settimana a Firenze a due passi dalla casa di Dante. Un giorno, vado a vedere la piccola chiesa, Santa Margherita dei Cerchi, dove si trova la tomba di Beatrice. L’amata, l’ispirazione del poeta, sempre irraggiungibile. Un amore inappagato, segnato dalla distanza, dal silenzio.
Non avrei un vero bisogno di conoscere questa lingua. Non vivo in Italia, non ho amici italiani. Ho solo il desiderio. Ma alla fine un desiderio non è altro che un bisogno folle. Come in tanti rapporti passionali, la mia infatuazione diventerà una devozione, un’ossessione. Ci sarà sempre qualcosa di squilibrato, di non corrisposto. Mi sono innamorata, ma ciò che amo resta indifferente. La lingua non avrà mai bisogno di me.
Alla fine della settimana, dopo aver visto tanti palazzi, tanti affreschi, torno in America. Porto con me delle cartoline, dei regalini, per ricordare il viaggio. Eppure il ricordo più chiaro, più vivo, è qualcosa di immateriale. Quando penso all’Italia, sento di nuovo certe parole, certe frasi. Sento la loro mancanza. Questa mancanza mi spinge, pian piano, a imparare la lingua. Mi sento sia incalzata dal desiderio sia esitante, timida. Chiedo all’italiano, con una lieve impazienza: Permesso?
L’ESILIO
La mia relazione con l’italiano si svolge in esilio, in uno stato di separazione.
Ogni lingua appartiene a un luogo specifico. Può migrare, può diffondersi. Ma di solito è legata a un territorio geografico, un Paese. L’italiano appartiene soprattutto all’Italia, mentre io vivo in un altro continente, dove non lo si può incontrare facilmente.
Penso a Dante, che attese per nove anni prima di parlare con Beatrice. Penso a Ovidio, bandito da Roma in un luogo remoto. In un avamposto linguistico, circondato da suoni alieni.
Penso a mia madre, che scrive poesie in bengalese, in America. Lei non può trovare, perfino quasi cinquant’anni dopo che vi si è trasferita, un libro scritto nella sua lingua.
In un certo
senso mi sono abituata a una specie di esilio linguistico. La mia lingua madre, il bengalese, in America è straniera. Quando si vive in un Paese in cui la propria lingua è considerata straniera, si può provare un senso di straniamento continuo. Si parla una lingua segreta, ignota, priva di corrispondenze con l’ambiente. Una mancanza che crea una distanza dentro di sé.
Nel mio caso c’è un’altra distanza, un altro scisma. Non conosco il bengalese alla perfezione. Non so leggerlo, neanche scriverlo. Parlo con un accento, senza autorità, per cui ho sempre percepito una sconnessura tra me ed esso. Di conseguenza ritengo che la mia lingua madre sia anche, paradossalmente, una lingua straniera.
In quanto all’italiano, l’esilio ha un aspetto diverso. Non appena ci siamo conosciuti, io e l’italiano ci siamo allontanati. La mia nostalgia sembra una sciocchezza. Eppure, la sento.
Com’è possibile, sentirmi esiliata da una lingua che non è la mia? Che non conosco? Forse perché io sono una scrittrice che non appartiene del tutto a nessuna lingua.
Compro un libro. S’intitola Teach Yourself Italian. Un titolo esortativo, pieno di speranza, di possibilità. Come se fosse possibile imparare da soli.
Avendo studiato il latino per molti anni, trovo i primi capitoli di questo manuale abbastanza facili. Riesco a memorizzare qualche coniugazione, a fare gli esercizi. Ma non mi piace il silenzio, l’isolamento del processo autodidattico. Sembra distaccato, sbagliato. Come se studiassi il funzionamento di uno strumento musicale, senza mai suonarlo.
Decido, all’università, di scrivere la mia tesi di dottorato sull’influenza dell’architettura italiana su alcuni drammaturghi inglesi del diciassettesimo secolo. Mi chiedo la ragione per cui certi drammaturghi abbiano deciso di ambientare le loro tragedie, scritte in inglese, nei palazzi italiani. La tesi parlerà di un altro scisma tra la lingua e l’ambiente. L’argomento mi dà un secondo motivo per studiare l’italiano.
Frequento corsi elementari. La prima insegnante è una signora milanese che vive a Boston. Faccio i compiti, supero gli esami. Ma quando provo a leggere La ciociara di Moravia, dopo due anni di studi, la capisco a malapena. Sottolineo quasi ogni parola su ogni pagina. Devo controllare continuamente il dizionario.
Nella primavera del 2000 vado a Venezia, quasi sei anni dopo il mio viaggio a Firenze. Porto con me, oltre al dizionario, un taccuino in cui prendo, sull’ultima pagina, appunti che potrebbero essere utili: Saprebbe dirmi? Dove si trova? Come si fa per andare? Mi ricordo la differenza tra buono e bello. Mi sento preparata. In realtà, a Venezia, riesco appena a chiedere un’indicazione per la strada, una sveglia all’albergo. Riesco a ordinare in un ristorante e scambiare due parole con una commessa. Nulla di più. Nonostante sia tornata in Italia, mi sento ancora esiliata dalla lingua.
Qualche mese dopo ricevo un invito al Festival della letteratura di Mantova. Lì incontro i miei primi editori italiani. Una di loro è, inoltre, la mia traduttrice. La casa editrice ha un nome spagnolo, Marcos y Marcos. Loro sono italiani. Si chiamano Marco e Claudia.
Devo fare tutte le interviste, le mie presentazioni, in inglese. C’è sempre un interprete accanto a me. Seguo più o meno l’italiano, ma non riesco a esprimermi, spiegarmi, senza l’inglese. Mi sento limitata. Non è sufficiente ciò che ho imparato in America, in aula. La mia comprensione è talmente scarna che, qui in Italia, non mi aiuta. La lingua sembra, tuttora, un cancello chiuso. Sono sulla soglia, vedo all’interno, ma il cancello non si apre.
Marco e Claudia mi danno la chiave. Quando menziono di aver studiato un po’ d’italiano, e che vorrei migliorarlo, smettono di parlare con me in inglese. Passano alla loro lingua, benché io riesca a rispondere solo in modo semplicissimo. Malgrado tutti i miei errori, malgrado io non capisca completamente quello che dicono. Malgrado il fatto che loro parlano inglese molto meglio di quanto io parli italiano.
Loro tollerano i miei sbagli. Mi correggono, mi incoraggiano, mi forniscono le parole che mi mancano. Parlano con chiarezza, con pazienza. Così come i genitori con i loro bambini. Come si impara la lingua madre. Mi rendo conto di non aver imparato l’inglese in questa maniera.
Claudia e Marco, che hanno tradotto e pubblicato il mio primo libro in italiano, e che mi ospitano in Italia per la prima volta da scrittrice, mi regalano questa svolta. Grazie a loro, a Mantova, mi trovo finalmente dentro la lingua. Perché alla fine per imparare una lingua, per sentirsi legati a essa, bisogna avere un dialogo, per quanto infantile, per quanto imperfetto.
LE CONVERSAZIONI
Tornata in America, voglio continuare a parlare italiano. Ma con chi? Conosco alcune persone a New York che lo sanno alla perfezione. Mi vergogno a parlare con loro. Mi serve qualcuno con cui posso stentare, posso fallire.
Un giorno vado alla New York University, all’istituto d’italiano, per intervistare una celebre scrittrice romana che ha vinto il premio Strega. Mi trovo in una sala strapiena, in cui tutti parlano un italiano impeccabile tranne me.
Mi accoglie il direttore. Gli dico che avrei voluto fare l’intervista in italiano. Che ho studiato la lingua anni fa, ma non riesco a parlare bene.
«Bisogno praticare» gli dico.
«Hai bisogno di pratica» mi risponde gentilmente.
Nel 2004 mio marito mi dà una cosa. Un pezzettino di carta strappato da un annuncio, visto per caso, per strada, nel nostro quartiere a Brooklyn. C’è scritto: «Imparare l’italiano». Lo considero un segnale. Chiamo il numero, fisso un appuntamento. Arriva a casa mia una donna simpatica, energica, anche lei di origine milanese. Insegna ai bambini in una scuola privata, abita in periferia. Mi chiede come mai io voglia imparare la lingua.
Spiego che andrò, in estate, a Roma, per partecipare a un altro festival letterario. Sembra un motivo ragionevole. Non rivelo che l’italiano è un mio estro. Che covo una speranza – anzi, il sogno – di conoscerlo bene. Non faccio capire che sto cercando un modo per tener viva una lingua che non c’entra con la mia vita. Che mi angoscio, che mi sento incompleta. Come se l’italiano fosse un libro che non riesco, per quanto lavori, a realizzare.
Ci vediamo una volta alla settimana, per un’oretta. Sono incinta di mia figlia, che nascerà a novembre. Provo a fare due chiacchiere. Alla conclusione di ogni lezione, lei mi dà una lunga lista di parole che mi mancavano durante la conversazione. La ripasso assiduamente. La metto in una cartella. Non riesco a ricordarmele.
Al festival di Roma riesco a scambiare tre, quattro, magari cinque frasi con qualcuno. Dopodiché mi fermo; non mi è possibile fare di più. Conto le frasi, come se fossero i colpi durante una partita di tennis, come se fossero le bracciate quando si impara a nuotare.
Torniamo alla metafora del lago, quello che voglio attraversare. Ora posso camminare nell’acqua, fino al ginocchio, fino alla vita. Ma devo ancora poggiare i piedi sul fondo. Appunto, sono costretta a fare ciò che fanno quelli che non sanno nuotare.
Nonostante le conversazioni, la lingua resta un elemento sfuggente, evanescente. Compare solo grazie all’insegnante. Lei la rende presente a casa mia per un’ora, poi la porta via. Sembra concreta, palpabile, solo quando sono insieme a lei.
Nasce mia figlia, passano altri quattro anni. Porto a termine un altro libro. Dopo la pubblicazione nel 2008, ricevo un altro invito in Italia, per promuoverlo. Per prepararmi trovo una nuova insegnante. Una giovane entusiasta, premurosa, di Bergamo. Anche lei viene una volta alla settimana da me. Parliamo sul divano, una accanto all’altra. Facciamo amicizia. La mia comprensione migliora sporadicamente. L’insegnante mi incoraggia molto, mi dice che parlo bene la lingua, dice che in Italia ce la farò. Ma non è vero. Quando vado a Milano, quando provo a parlare in modo intelligente, in modo scorrevole, mi rendo sempre conto degli sbagli che mi impacciano, che mi confondono, e mi sento avvilita più che mai.
Nel 2009 inizio a studiare con la terza insegnante privata. Una signora veneziana che si è trasferita a Brooklyn più di trent’anni fa, che ha cresciuto i suoi figli in America. Vedova, abita con un cane mansueto, sempre ai suoi piedi, in una casa circondata dal glicine, vicina al ponte di Verrazzano. Ci metto quasi un�
�ora per raggiungerla. Prendo la metropolitana fino al confine di Brooklyn, quasi al capolinea.
Amo questo viaggio. Esco da casa, lascio alle spalle il resto della mia vita. Non penso alla mia scrittura. Dimentico, per qualche ora, le altre lingue che conosco. Sembra, ogni volta, una piccola fuga. Mi aspetta un luogo in cui conta solo l’italiano. Un riparo da cui si sprigiona una nuova realtà.
Sono molto affezionata alla mia insegnante. Sebbene per quattro anni ci diamo del lei, abbiamo un rapporto stretto, familiare. Sediamo al suo piccolo tavolo, su una panca di legno in cucina. Vedo i suoi libri sugli scaffali, le foto dei suoi nipotini. Magnifiche pentole di ottone appese alle pareti. Ricomincio, a casa sua, da capo: il periodo ipotetico, il discorso indiretto, l’uso della forma passiva. Con lei il mio progetto sembra più possibile che impossibile. Con lei la mia strana dedizione alla lingua sembra più una vocazione che una sciocchezza.
Parliamo delle nostre vite, dello stato del mondo. Facciamo una valanga di esercizi, aridi ma necessari. L’insegnante mi corregge continuamente. Ascoltandola, prendo appunti su un taccuino. Dopo le lezioni mi sento sia spossata sia già pronta per la prossima. Dopo averla salutata, dopo aver chiuso il cancello dietro di me, non vedo l’ora di tornare.
A un certo punto le lezioni con l’insegnante veneziana diventano il mio impegno preferito. Studiando con lei, diventa chiaro il prossimo passo inevitabile in questo mio strambo viaggio linguistico. A un certo punto, decido di trasferirmi in Italia.
LA RINUNCIA
Scelgo Roma. Una città che mi affascina fin da piccola, che mi conquista subito. La prima volta in cui ci sono stata, nel 2003, ho provato un senso di rapimento, un’affinità. Mi sembrava di conoscerla già. Sapevo, dopo solo un paio di giorni, di essere destinata a vivere lì.

 The Namesake
The Namesake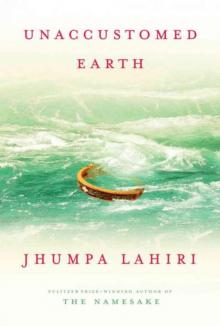 Nobody's Business
Nobody's Business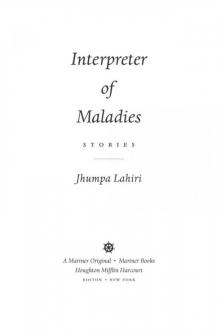 Interpreter of Maladies
Interpreter of Maladies Hell-Heaven
Hell-Heaven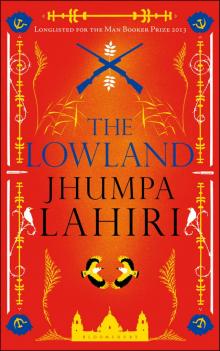 The Lowland
The Lowland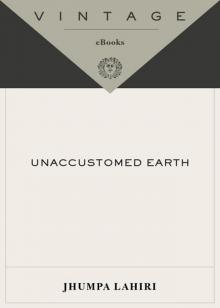 Unaccustomed Earth
Unaccustomed Earth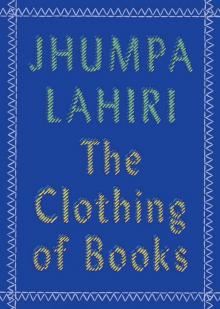 The Clothing of Books
The Clothing of Books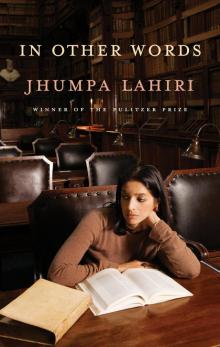 In Other Words
In Other Words The Penguin Book of Italian Short Stories
The Penguin Book of Italian Short Stories